Andrea Carraro è un calibratore di parole: questa è la definizione che trovo più adatta se penso alla sua scrittura attenta, smussata, asciutta, per niente ridondante. Nella sua indagine narrativa, sin dalla prime prove, (ha esordito negli anni Novanta, con il romanzo A denti stretti, raggiungendo il grande pubblico già quattro anni dopo con i Il branco e successivamente L’erba cattiva, ed è autore, sin dal principio della sua carriera, di diverse raccolte di racconti) è possibile accedere sempre ad una realtà veritiera, mai rassicurante, raccontata senza sotterfugi e tratteggiata nelle sue venature più concrete. Le opere di Carraro non condannano né assolvono nessuno e coinvolgono attivamente il lettore, continuamente stimolato da vicende intense, robuste che non confortano quasi mai ma che, al contrario, suggeriscono una continua e meticolosa analisi su se stessi. La voce di Carraro è quella di un narratore potente, che non ha bisogno di sovrastare la pagina con il suo ego. L’intento più sorprendente della sua scrittura, forse il migliore, è quello di rintracciare maggiormente le somiglianze invece delle differenze tra gli esseri umani, laddove quelle analogie, appunto, ci mettono di fronte noi stessi, capaci per natura, e allo stesso modo, sia del sublime che dell’ignobile.
Le tue storie sono spesso ambientate nelle periferie delle grandi città, dove l’emarginazione e il degrado condizionano le personalità e i sentimenti di chi vi nasce. Eppure nonostante ciò, nei tuoi scritti non appaiono mai sanzioni o remissioni…
All’inizio della mia carriera mi sono concentrato molto sugli ambienti di periferia, ai margini delle città non per un motivo sociologico ma per un motivo diverso, cioè perché mi sembrava che in quelle zone dove in genere ci sono molti problemi sociali, alcuni elementi essenziali dell’esistenza umana fossero più visibili, più evidenti. Negli ultimi anni, invece, mi sto concentrando anche sugli strati sociali più alti, mi interessa comprendere i comportamenti umani non solo negli ambienti degradati.
Quali sono i tuoi scrittori di riferimento, che hanno contribuito alla tua formazione?
Io sono un autodidatta, le mie letture sono sempre state caotiche, casuali, disordinate, non ho seguito un percorso preciso o comunque accademico. Gli scrittori che mi hanno influenzato sono molti sia italiani che stranieri, e nel caso di questi ultimi io sono molto grato alle traduzioni perché, molto spesso, non sono in grado di leggere gli autori in lingua originale. Posso citare alla rinfusa i nomi per me più importanti: senz’altro Conrad, Maupassant soprattutto per la forma racconto che mi è molto cara e per lo stesso motivo anche Carver ed Hemingway. Per il romanzo sono stati essenziali Flaubert, Céline e Proust. Quest’ultimo lo sto rileggendo per la terza volta proprio ultimamente, perché ogni volta riesco ad individuare dettagli e aspetti che nelle volte precedenti non avevo notato. Tra gli italiani certamente Moravia e Pasolini, non solo il Pasolini narratore ma anche il Pasolini poeta e cronista dei costumi, della nostra cultura.
Tu ami molto il cinema, e da uno dei tuoi romanzi più noti, Il branco, è nato un film omonimo diretto da Marco Risi. Quali sono, se ci sono ancora, gli esiti migliori di connubio tra cinema e letteratura?
La traduzione dei romanzi in film è una questione complessa, che il più delle volte ci lascia delusi. Non c’è una regola in questo caso ovvero, non sempre il romanzo è buono e il film delude, accade anche il contrario: ci troviamo dinanzi a film che sono migliori rispetto al romanzo a cui sono ispirati, pensiamo ad esempio a Shining, che è tratto da un romanzo che, seppur bello, a mio parere non raggiunge i livelli del film. Truffaut sosteneva che i film migliori nascono sempre da opere letterarie di livello non altissimo, addirittura a volte mediocri, con molte imprecisioni. Per quel che riguarda Il branco, ritengo che sia un film bello, la parola giusta forse è robusto. Inizialmente alcune interpretazioni che Marco Risi diede del mio romanzo mi fecero storcere il naso ma questo è normalissimo, ma rivederlo a distanza di tempo, con altri strumenti e altri punti di vista acquisiti, mi ha fatto capire sempre di più che si trattasse davvero di un buon lavoro. Se c’è un difetto? Forse quello di essere troppo fedele al romanzo. In ogni caso è un film importante, purtroppo massacrato dalla critica in maniera per me assurda, un po’ ipocrita, Il tema del libro e del film era coraggiosissimo vent’anni fa e lo è tuttora, dunque il punto di vista tutto maschile su una tematica simile ha disturbato da un punto di vista morale. Quando ci si trova di fronte a questioni di un certo tipo, che investono la sfera morale, molto spesso si indugia su sfere stilistiche per non affrontare il vero punto della questione che è quello etico.
Questo 2017 è stato certamente importante per te: Il seme bianco ha ripubblicato il tuo L’erba cattiva, che uscì nel 1996 per Giunti e in estate è uscito per Castelvecchi Sacrificio, il tuo nuovo romanzo. Rileggendoti ora e facendo un confronto tra la tua scrittura attuale e quella del passato, cos’è rimasto uguale e cosa è cambiato?
Forse nel Sacrificio ho riacquistato un po’ del lirismo di quel libro che in altre opere più recenti si era un poco affievolito. Comunque per me rileggere miei vecchi libri a volte fa uno strano effetto, come se non li avessi scritti io. Un senso di estraneità, ma anche di nuova scoperta. L’erba cattiva non fu trattato all’epoca come forse meritava – veniva dopo Il branco e venne un po’ oscurato – non solo mediaticamente – da quel romanzo più famoso. È un romanzo tragico, ma anche lirico, e perfino sentimentale in certi momenti… Sacrificio è la storia di un padre che tenta in tutti i modi di salvare la propria figlia tossicodipendente. Si tratta di è un romanzo intenso e doloroso, a tratti visionario, che sa regalare pagine talvolta sofferte e ciniche, talvolta di grande tenerezza. Uno dei temi chiave del libro mi sembra quello del fallimento: in cosa ha fallito o crede di aver fallito il protagonista? Molti sono i temi, ma sì il fallimento è uno dei più importanti. Il protagonista si sente un fallito in ogni senso, come padre come marito come uomo come cristiano. È schiacciato dai sensi di colpa. In qualche intervista mi è capitato di dire, un po’ pomposamente in verità, che Giorgio assume su di sé tutte le colpe del mondo, per sottolineare l’aspetto cristologico, biblico di questa storia di passione e sacrificio. Il sacrificio è quasi un archetipo della cultura cristiana occidentale: Abramo sta per sacrificare suo figlio quando Dio gli ferma la mano. Giorgio sacrifica invece se stesso per salvare la figlia – attraverso un patto con il Diavolo, anche se il Diavolo forse è soltanto nella sua mente e nella sua coscienza.
Quali sono le variabili che danno ad un testo il potere di “persuadere” il lettore?
Mi piace il lettore attivo, quello che mentre legge si fa delle domande, che si identifica nel personaggio e che eventualmente soffre o è deluso se e quando questo personaggio compie un’azione contraria a quella presunta, insomma un lettore che può non essere d’accordo col personaggio specie quando questo agisce su sfere che il lettore stesso fa fatica a riconoscere come proprie. Non penso che la letteratura sia didattica o didascalica, chi scrive deve però avere un’illusione che quel che ha prodotto possa sortire qualche effetto sugli altri, altrimenti non ha molto senso farlo.
Hai scritto romanzi, una silloge poetica e molti racconti e la critica più autorevole ti annovera tra i maggiori autori di narrativa breve nel nostro paese (l’anno scorso Melville ha pubblicato la raccolta di Tutti i racconti). Sai dirmi qualcosa a proposito di questa gerarchia, più o meno palesata, che ha collocato il romanzo all’apice di una piramide e il racconto in una posizione decisamente inferiore?
Noi italiani siamo tradizionalmente più vocati alla forma breve, non lo dico io è la nostra storia letteraria a parlarne, pensiamo ai novellieri del Trecento ma anche a Verga a Pirandello, ne cito solo alcuni perché la lista sarebbe lunghissima. Gli editori dicono che le raccolte di racconti vendono poco e per questo fanno fatica a pubblicarle, io credo che in parte questa sia una scusa, una paura di rischiare. Con i racconti si rischia perché vanno contro la mitologia del romanzo e la fascinazione che vi si è creata intorno.
Negli ultimi anni, l’utilizzo di Facebook e dei social da parte degli artisti, e in questo caso degli scrittori è diventato molto frequente. In particolare noto questa diffusa urgenza del dire, del precisare di stare scrivendo, di doverlo ricordare ogni giorno: scrivere di scrivere, dunque.
I social hanno segnato un’esaltazione del sé, è vero ed io mi sono trovato spesso a segnalare queste tue stesse perplessità proprio sui social. Io cerco sempre di dominarmi, ognuno sceglie di fare quello che vuole, in base alla propria consapevolezza, al proprio modo di intendere le cose e di viverle. Attualmente i social ci sono, è inutile agire dicendo il contrario anche se sono fermamente convinto che sarebbe meglio non starci, ma nonostante ciò ci stiamo tutti.
L’autore ha una responsabilità con il proprio tempo?
Io credo che alla fine ognuno decida cosa e come raccontare. Io per parte mia credo che narrare il proprio tempo sia una necessità storica, farlo da tutti i punti di vista, anche quelli meno consolatori ed edulcorati e ritengo che finora la nostra letteratura (parlo di quella contemporanea) si sia sufficientemente disinteressata alle svariate problematiche sociali che investono il nostro paese, per dirne una quella del lavoro e della precarietà – ma ce ne sono tante altre. Ci sono fortunatamente delle eccezioni e sono quelle che mi interessano.

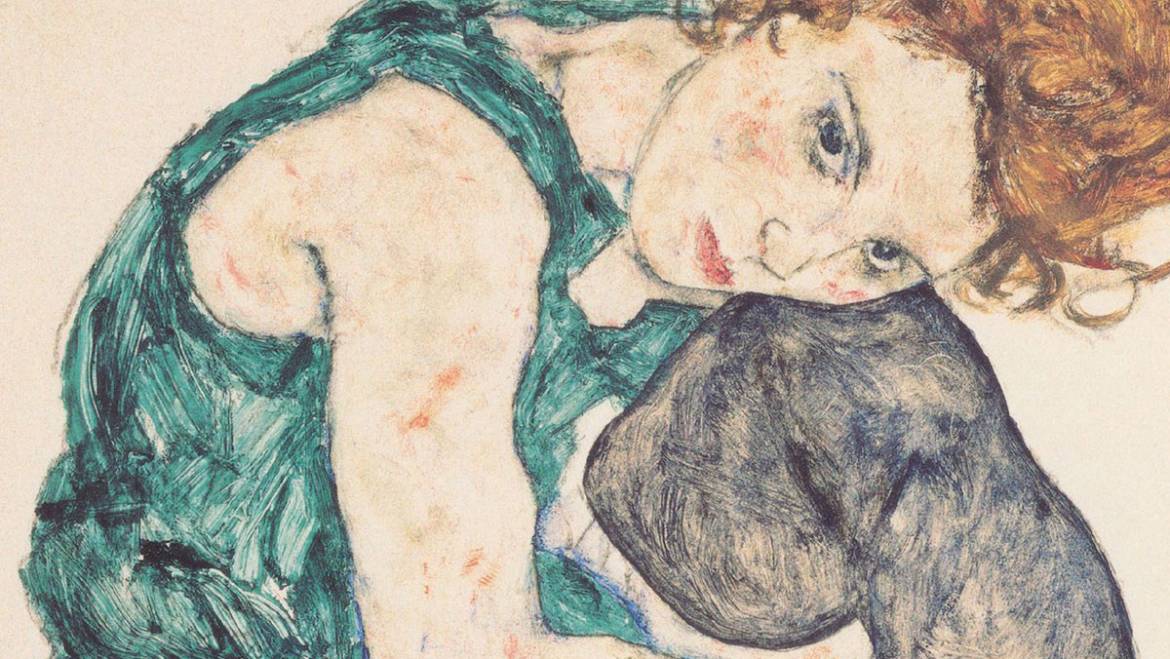
Aggiungi commento